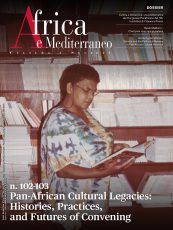Memorie della migrazione, biografie femminili, materialità
Africa e Mediterraneo n. 101 (1/25)
Memorie della migrazione, biografie femminili, materialità | Memories of migration, female biographies, materiality
di Sandra Federici ed Enrica Picarelli
Le migrazioni internazionali sono il fenomeno antropologico che ha definito di più la storia degli ultimi decenni, con effetti profondi e diffusi sulla convivenza dei popoli e la tenuta delle istituzioni nazionali e internazionali. Al mito degli anni ’90 del Novecento che immaginava un pianeta globalizzato, popolato da individui dotati di “cittadinanza flessibile”, si è sostituita la visione tossica e “territorializzata” di stati-nazione blindati dove la mobilità si configura sempre più come un privilegio anziché un diritto. Questa visione si traduce in un pensiero dell’esclusione supportato da politiche che, oltre a respingere fisicamente le persone migranti, ne espropriano e sopprimono la voce e, in particolare nel caso italiano, impostano normative e prassi del soggiorno secondo una modalità che rende l’effettivo esercizio dei diritti, primo fra tutti quello alla cittadinanza, un ostacolo costante. Nel piano burocratico-amministrativo le difficoltà sono innumerevoli, e quello che potrebbe essere semplice viene reso sempre più irraggiungibile, lento, lontano. Gli aspetti legati alle necessità economiche per molte famiglie di origine straniera (necessità non solo del vivere in Italia ma anche di sostenere famiglie rimaste nei paesi di origine) sono tali da spingere continuamente le persone a forme di adattamento e abbassamento delle aspettative di carriera e di espressione. Ciononostante le persone – e in alcuni casi interi popoli – si spostano, sperimentando nuove forme di mobilità che plasmano la Storia e rendono i migranti i primi protagonisti degli stravolgimenti geopolitici di questi anni.
Abbiamo dedicato questo numero di Africa e Mediterraneo ad approfondire quello che esiste e r-esiste nello scarto tra le storie – biografie espropriate, violate, silenziate – di queste persone e la Storia che le ingloba e sovrascrive. Ci siamo soffermate soprattutto sul ruolo degli “oggetti della memoria” in queste difficili esperienze e nelle loro scritture: quei beni personali che suscitano ricordi deliberati o involontari della terra di origine, della cultura domestica, delle relazioni famigliari e sociali e del vissuto del passato precedente alla migrazione. Questi oggetti si muovono con le persone, a volte anche di più, creano paesaggi affettivi e reti di relazioni, custodiscono mondi interiori, riproducendo identità in divenire e negoziando i termini dell’appartenenza in condizioni di spaesamento e dislocazione.
Questo universo materiale e le sue pratiche culturali offrono un punto di osservazione sui processi di deterritorializzazione e ri-territorializzazione del nostro mondo, aiutandoci a comprendere meglio uno scenario in cui le società sembrano contemporaneamente “liquefarsi” e irrigidirsi sull’asse di “differenze” identitarie percepite come sempre più esclusive e inconciliabili. Gli oggetti preservano la genealogia e rendono tangibile l’esperienza della migrazione e la coscienza della diaspora. Si fanno simbolo e catalizzatore di significati culturali, di memoria identitaria, di storia, ma anche di aspettative per il domani. Gli oggetti proiettano l’identità nel passato, nel presente e nel futuro, guardando contemporaneamente in più direzioni, articolando ritorni e nuovi inizi e veicolando la trasmissione dell’appartenenza culturale alle generazioni future. Sono, insomma, direttamente coinvolti nella configurazione, che lo studioso AbdouMaliq Simone definisce “worlding from below” (2001), di orizzonti esistenziali in cui coesistono luoghi e temporalità diverse, ma anche abitudini, convenzioni sociali, relazioni di potere.
Torna utile la definizione di migrant worlds (mondi migranti) che Paul Basu e Simon Coleman elaborano in uno studio dedicato proprio alla materialità della migrazione (2008: 313). Per questi autori la migrazione è un fenomeno che si sostanzia appunto nello spostamento da un luogo a un altro di “risorse materiali e immateriali” che, viaggiando, si trasformano. Caratteristica principale del fenomeno è la relazione che intercorre tra queste “risorse”, una relazione che crea un universo esistenziale organico in cui persone e oggetti si creano reciprocamente. La prospettiva materiale sulla migrazione si fa dunque attenta alla dimensione “ecologica” dell’esperienza di transito e ai modi attraverso cui il concreto e l’immateriale entrano in relazione non solo reciproca, ma con gli spazi che attraversano e che inevitabilmente trasformano.
Gli articoli che pubblichiamo presentano riflessioni critiche sui mondi formatisi nelle relazioni tra persone e oggetti della memoria da molteplici prospettive critiche: letteratura, sociologia, antropologia, ma anche autobiografia e autoetnografia. Dalle fotografie agli oggetti utilizzati nelle cerimonie di benvenuto, al cibo, all’argilla grezza da plasmare, gli oggetti collegano dimensione pubblica e privata dando corpo a nuove forme di cura e appartenenza.
Cover: Monia Ben Hamouda, “Aniconism as Figurative Urgency (Hamra)”, 2022. Installation view of “Hamra”, Ariel Feminisms in the Aesthetics, Copenhagen, 2022. Laser cut steel, spice powders 200x150x25 cm. Courtesy of Monia Ben Hamouda, Milan and ChertLüdde, Berlin.
Africa e Mediterraneo n. 101 (1/25); Lingua: Contiene articoli in italiano inglese e francese; Codice ISSN: 1121-8495; Formato: 88 pp., 21×28 cm, brossura filo refe.